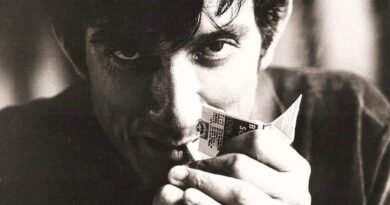SPECIALE / Il Museo della Forma Urbis: una passeggiata nella Roma dell’età imperiale
Il museo della Forma Urbis si trova a Roma, al Celio, nel cuore della capitale. L’accesso consente al visitatore di vivere un’esperienza significativa ed affascinante poiché permette di vedere una pianta dell’Urbe di età severiana: un antico e straordinario reperto risalente all’epoca imperiale, ben conservato, attraverso il quale la Città Eterna riproduce la sua forma e conserva la sua stessa memoria.
La Forma Urbis: cos’è
L’espressione latina “Forma Urbis Severiana” (“Forma Urbis Romae”, “Forma Urbis Marmorea” o “Pianta marmorea severiana”) indica la mappa marmorea che raffigura il paesaggio urbano della Roma antica: un’opera che ha il merito di sottolineare le sovrapposizioni moderne sugli edifici degli antichi romani. La pianta appartiene ed è parte integrante delle collezioni dei Musei Capitolini dal 1742.
Quest’opera d’arte illustra minuziosamente la topografia della città di Roma nel III secolo d.C. ed è specificatamente la versione monumentale dei documenti catastali del tempo che erano depositati negli archivi della Prefettura, collocata da Settimio Severo nel Foro nel 211, anno della morte dello stesso imperatore.
La Forma Urbis fu scoperta nel 1562 dagli uomini del cardinale Alessandro Farnese e i suoi frammenti vennero trasportati a Palazzo Farnese. Dell’opera ne viene esposto oggi circa un decimo della sua versione originale, in quanto molti dei suoi frammenti sono andati perduti nel tempo. I frammenti superstiti della Forma sono 186, conservati all’interno dell’omonimo museo a Roma e, sebbene rappresentino solo il 10-15% della struttura originaria della mappa, simboleggiano una delle più rare ed eccezionali testimonianze giunte dall’antichità della maestosità della Roma imperiale e dello sbalorditivo ingegno artistico ed ingegneristico dei romani.
I disegni delle parti disperse della pianta furono realizzati su commissione dell’antiquario Giovan Pietro Bellori nel 1600, salvandole dal dimenticatoio. In seguito, nel 1744, Papa Benedetto XIV ottenne i frammenti sopravvissuti dalla corona di Spagna, dal momento che Filippo V di Spagna aveva sposato Isabella Farnese, e li fece trasferire presso i Musei Capitolini, organizzandone la prima esposizione.
L’ultimo frammento della Forma Urbis, relativo alla lastra numero 31 e raffigurante l’area del Ghetto, è stato rinvenuto nel 2014 nel corso dei lavori che hanno interessato Palazzo Maffei Marescotti.
Attualmente è in fase di elaborazione alla Stanford University un progetto finalizzato alla realizzazione di un database online dei frammenti esistenti, ma che al contempo cerca di ricostruire la versione originaria della pianta mediante l’ausilio delle moderne tecnologie. Il progetto conferma l’attenzione che da sempre i ricercatori stranieri (americani in particolare) rivolgono allo studio della Roma antica.
La mappa, che in origine era gigantesca, è stata scolpita su marmo tra il 203 d.C. (data di inaugurazione del Settizonio, raffigurato al suo interno), e nel 211 d.C. si componeva di lastre rettangolari, per volontà dell’imperatore Settimio Severo. Con molta probabilità, la pianta fu commissionata in occasione della rimessa a nuovo di alcune parti del Tempio della Pace (o “Foro della Pace”), che erano state compromesse a causa di un grande incendio scoppiato nel 191 d.C. All’epoca le fu attribuita infatti una funzione di esaltazione e promozione del potere e dei grandiosi monumenti della città e fu collocata ed esibita al pubblico su una parete di un’aula del Tempio stesso.
Le dimensioni originarie della pianta erano di circa 18 metri di lunghezza per 13 metri di altezza circa, ed era composta da 140 lastre di marmo, che erano apposte alla parete tramite perni di ferro. Lo schema della mappa venne inciso sulle lastre, una volta che queste furono disposte sul muro. Nella sua versione integrale, la mappa riproduceva le planimetrie degli edifici di Roma, riportando all’incirca 13.550.00 m2 della superficie della città. In particolare, l’opera ritrae in maniera dettagliata il piano terra di tutti i palazzi, includendo scale interne e colonnati.
Il museo: quando è stato aperto e dove si trova
Il museo si trova all’interno del Parco archeologico del Celio: più precisamente, è stato allestito all’interno dell’edificio che in passato ospitava la sede della Palestra della GIL (Gioventù Italiana del Littorio). Il merito della sua riapertura al pubblico deve essere attribuito agli interventi gestiti dalla direzione scientifica della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali di Roma Capitale.
Il Parco occupa il settore settentrionale del colle Celio (uno dei sette colli della Città di Roma): è immerso in un’area verde (rivolta verso il Colosseo) e comprende al suo interno anche un giardino archeologico (adiacente al museo), in cui vengono custoditi importanti reliquie e reperti di grande valore. Tra i tanti, le fondazioni perimetrali del tempio del Divo Claudio e i materiali appartenenti alle collezioni dell’ex Antiquarium Comunale.
La Forma Urbis nel suo nuovo allestimento è stata riaperta all’interno dell’omonimo museo dopo quasi 100 anni. Il Parco archeologico è stato reso accessibile ai visitatori il 12 gennaio 2024. L’inaugurazione del museo, che si è svolta l’11 gennaio, ha visto la partecipazione di figure di spicco nel panorama politico e culturale italiano: Roberto Gualtieri (attuale sindaco di Roma), Miguel Gotor (assessore capitolino alla Cultura) e Claudio Parisi Presicce (sovrintendente capitolino ai Beni culturali).
Di particolare interesse, l’allestimento pavimentale della mappa, che ne ha agevolato la comprensione. Ciò significa che la grande iconografia marmorea della Roma antica è posizionata, coperta da una lastra di vetro, sul pavimento della sala principale del museo, in maniera tale che il visitatore, calpestandolo, possa suggestivamente immaginare di passeggiare tra le strade e gli edifici della città imperiale.
Perché visitare il museo?
La visita del Parco archeologico del Celio rappresenta una rara e importante opportunità che consente al visitatore, viaggiando indietro di secoli, di accrescere la propria conoscenza della Roma imperiale. Quella del Museo della Forma Urbis in particolare costituisce un’occasione imperdibile per gli appassionati di storia d’arte e, soprattutto, di archeologia: è parte del patrimonio culturale dell’Italia, una finestra sull’arte antica che consente di vivere nel passato e, insieme, di capire meglio lo sviluppo urbanistico di Roma.
Mentre l’accesso al Parco archeologico è gratuito per tutti i giorni della settimana, è previsto il pagamento di un biglietto per l’accesso al museo (il prezzo varia dai 5.50 euro ai 9 euro, a seconda che il visitatore sia o meno un residente); la chiusura del museo è fissata per il lunedì.
Il Museo della Forma Urbis è un gioiello culturale di eccezionale valore ed “è un luogo che celebra la storia millenaria della capitale”, ha detto Miguel Gotor: accedendovi, il visitatore potrà vivere un’esperienza affascinante, ammirando il nuovo allestimento della mappa, la cui leggibilità non è però immediata; per tale ragione, si è cercato di facilitarla collocando i frammenti in maniera sovrapposta alla settecentesca Pianta Grande di Giovanni Battista Nolli (del 1748), a ricordare la configurazione di un puzzle.
Il visitatore potrà, allora, fare un divertente ed affascinante confronto tra la Roma antica e quella moderna, dilettandosi nella ricerca sia dei quartieri sia dei monumenti che da sempre hanno contrassegnato la storia della romanità (come il Colosseo ed il Circo Massimo), così come dei mutamenti che hanno interessato edifici oggi scomparsi, come il “Diribitorium”, l’antico edificio destinato allo scrutinio dei voti.